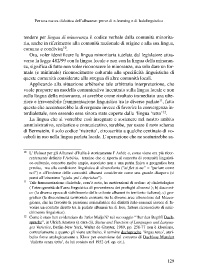Page 49 - PER UNA NUOVA DIDATTICA DELL'ALBANESE - Parte II
P. 49
Per una nuova didattica dell’albanese: prove di e-learning e di ludolinguistica
tendere per lingua di minoranza il codice verbale dalla comunità minorita-
ria, anche in riferimento alla comunità nazionale di origine e alla sua lingua,
10
comune e condivisa .
Ora, voler identificare la lingua minoritaria tutelata dal legislatore attra-
verso la legge 482/99 con la lingua locale e non con la lingua della minoran-
za, significa di fatto non voler riconoscere le minoranze, ma solo dare un for-
male (e minimale) riconoscimento culturale alle specificità linguistiche di
queste comunità considerate alla stregua di altre comunità locali.
Applicando alla situazione arbëreshe tale arbitraria interpretazione, che
vuole proporre un modello comunicativo incentrato sulla lingua locale e non
sulla lingua della minoranza, si avrebbe come risultato immediato una ulte-
11
riore e irreversibile frammentazione linguistica tra le diverse parlate , fatto
questo che accentuerebbe la divergenza invece di favorire la convergenza in-
12
terdialettale, non essendo esse sinora state coperte dalla ‘lingua ‘tetto’ .
La lingua che si vorrebbe così insegnare e sostenere nel nostro ambito
amministrativo, scolastico e comunicativo, sarebbe, per usare il noto schema
di Berrnstein, il solo codice ‘ristretto’, circoscritto a qualche centinaio di vo-
caboli in uso nella lingua parlata locale. L’operazione che ne scaturirebbe sa-
10
L’ Heimat per gli Albanesi d’Italia è storicamente l’ Arbër, o, come viene ora più ricor-
rentemente definito l’Arbëria, termine che ci riporta al concetto di comunità linguisti-
co-culturale, concetto molto ampio, associato non a una patria fisica o geografica ben
precisa, ma alla condizione linguistica di albanofonia (“ai flet si na” = “parlare come
noi”) e all’insieme delle comunità albanesi considerate come una grande diaspora (si
pensi all’etnonimo “gjaku ynë i shprishur”).
11
Tale frammentazione dialettale, com’è noto, ha motivazioni di ordine: a) dialettologico
( l’eterogeneità dell’area linguistica di provenienza dei profughi albanesi ); b) diacroni-
co (la diversa epoca di stabilimento delle colonie albanesi in territorio italiano); c) geo-
grafico (la discontinuità territoriale esistente tra le diverse aree albanofone del Mezzo-
giorno, che ha favorito la pressione assimilatrice dei dialetti italo-romanzi invece di fa-
vorire un contatto diretto tra le parlate albanesi tra di loro, fattore riconosciuto di arric-
chimento linguistico).
12
Come è stato ben evidenziato da ?arko Mulja?i? nel suo saggio “?ber den Begriff Dach-
sprache”, in Ulrich Ammon (a cura di), Status and Function of Languages and Langua-
ges Varieties, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1989, pp. 256-77 non è klossiano,
contrariamente a quanto gli viene attribuito, il termine dachsprache ‘lingua tetto’, attri-
buito forse analogicamente a Kloss per estensione del concetto di Dachlose Mundart
‘dialetto senza tetto’, da lui coniato nel 1952 (cf. op. cit.).
129